
CULTURA - ARTE

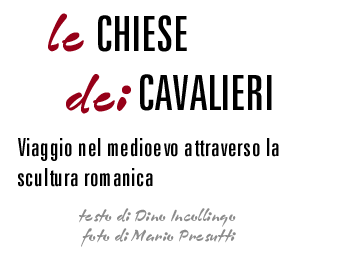
Articolo tratto da "Made in Molise" Anno I N.1
Le chiese romaniche, diversamente da altri oggetti architettonici, non hanno bisogno di un ambiente tipo, standard, sorgono un pò ovunque.
Appartengono ad un'epoca storica, tra la seconda metà dell'XI e l'inizio del XII secolo, in cui in Europa la Chiesa non rappresentava più solo un punto di riferimento spirituale, ma anche e soprattutto un sistema di potere con una raggiera di alleanze non proprio liturgiche, non faticava più di tanto a dominare masse di contadini, mercanti e nuovi borghesi, urtando contro gli interessi e il continuo espandersi di quei reami sorti dalla frantumazione dell'impero romano e consolidatisi e accresciuti di potenza con il passare dei secoli.
La particolare situazione, considerando anche una progressiva laicizzazione della cultura, rendeva necessario uno svecchiamento dei cliché comportamentali che reggevano il rapporto con il popolo.
In pratica, tra le altre cose, bisognava iniziare a farsi intendere dalla gente che non conosceva il latino scritto e da sempre parlava un volgare che evolveva verso il prototipo della lingua italiana, con un nuovo linguaggio.
La cultura si prestava a questo scopo. Con immagini sacre o direttamente riprese dai bestiari medievali il popolo poteva essere ammaestrato ed ammonito.
Se da un lato appariva l'esempio di personaggi biblici che ormai popolavano l'immenso paradiso, dall'altro fiammeggiavano draghi e bestie degli inferi capaci di infliggere atroci tormenti a chi distoglieva lo sguardo dall'Agnello Crucifero.
Sulle pareti esterne, sui portali, come sui capitelli delle chiese romaniche, quest'universo astratto, mentale, prendeva corpo ed otteneva i suoi risultati.
Quegli stessi che oggi, per buona pace di tutti, possono essere valutati più come artistici che dottrinali.
Nei territori che compongono l'attuale Molise, le prime serie tracce di arte romanica risalgono alla metà del XII secolo, periodo in cui nell'ambito di fluttuanti presenze imperiali si facevano largo piccoli potentati locali che, nell'eterno gioco degli equilibri tra potere spirituale e temporale, favorivano e foraggiavano in qualche modo la nascita di monasteri, cenobi e chiese, chiamando al proprio cospetto maestranze e scalpellini, per il corredo scultoreo, dalla vita ed abitudini nomadi.
Le principali vie di comunicazione ed i centri più importanti conobbero per primi le conseguenze di rotta nella stessa gestione della cultura.
Prima, la fortuna di una minima ripresa economica ed artistica era toccata solo a quei territori, si veda San Vincenzo a Volturno, dove la presenza dei Benedettini era stata massiccia e continua.
Lungo i tratturi, i veri e propri assi viari dell'età antica dell'attuale Molise, utili sia allo spostamento di eserciti che di grandi greggi transumati, sia all'epoca dei Sanniti che nel corso del Medioevo e dei tempi successivi, per persistere successivamente, e sino a pochi decenni fa, soltanto come grandi piste verdi della transumanza, furono erette le prime significative cappelle romaniche, alcune tuttora ben conservate.
Splendido esempio ne è costituito dalla chiesa di Santa Maria della Strada in agro di Matrice. Ma anche nei centri abitati non mancò episodio che potesse testimoniare di un certo risveglio nella sensibilità artistica.
Le cripte di Guglionesi (San Nicola e Sant'Adamo), quella di Santa Maria a Mare di Campomarino e di San Casto a Trivento raccolgono esperienze più che tangibili. Lungo il fiume Trigno, a ridosso di un'area che era già stata visitata e plasmata dai romani, allo stesso modo di quanto accade a Matrice ed a Vinchiaturo in località Monteverde, dove della chiesa di Santa Maria non restano che qualche traccia e le absidi diroccate, sorse la chiesa di Santa Maria di Canneto.
Sempre a ridosso del Trigno, su di un colle nei pressi di Civitanova del Sannio, dove già esisteva dall'anno 1002 una chiesetta benedettina, fu ingrandito l'edificio di culto dedicato a San Benedetto de Iumento Albo.
Nel XIII secolo la tendenza fu ancora più nitida, peraltro supportata da uno stile diventato più maturo.
La chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina è l'edificio che più di altri ha mantenuto integre le proprie strutture, ma non vanno tralasciate le chiese di San Nicola a Guglionesi, di San Giorgio e San Bartolomeo a Campobasso, della Cattedrale e di San Nicandro a Venafro, di Santa Maria Assunta a Ferrazzano, della badia di Santa Maria di Melanico in agro di Santa Croce di Magliano.
Altri resti di portali, campanili o semplici capitelli sono visibili in molte località.
I più rappresentativi sono i portali della chiesa di San Francesco ad Isernia e di San Martino a Castelpetroso (dove piccoli capitelli, forse appartenuti ad un ambone, sono visibili, riutilizzati, sul campanile).
Frammenti pur di un certo interesse sono rilevabili nelle strutture di edifici sacri in varie altre località del Molise.
Oggi una svolta nelle politiche di salvaguardia dei beni culturali potrebbe condurre ad un consolidamento strutturale e quindi ad una rinnovata fruibilità degli edifici di culto di epoca romanica.
I progetti già intrapresi, dalle Province di Campobasso e Isernia e dalla Regione Molise, per la sistemazione dei tratturi e le loro salvaguardia, dopo gli anni bui dell'abuso edilizio e dell'inciviltà generalizzata, comprese le opere di carattere storico-architettonico che vi furono costruite accanto nel corso dei secoli, quando gli eserciti avevano necessità di muoversi con estrema velocità, o i pellegrini dovevano raggiungere i santuari sacri nelle zone più a sud della penisola, o quando i pastori annualmente transumavano, danno già un chiaro segno di possibile schiarita in una situazione che per vari motivi non può essere trascinata avanti così com'era.
La ritrovata consistenza delle sculture e dell'apparato scultoreo di un edificio di importanza storico-architettonica può condurre alla riproduzione, senz'altro emotiva, di atmosfere medioevali per nulla buie, anzi tutt'altro.
Quell'atmosfera che, tralasciando qualche discutibile tentativo di vivacizzazione edilizio-creativa dell'area, si respira tuttora presso la chiesa di Santa Maria di Canneto, lungo il Fiume Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise, accanto e, in parte, al di sopra delle strutture di una villa rustica di epoca romana.
La datazione più attendibile dell'edificio, tralasciando ipotetiche interpretazioni di una ormai illeggibile iscrizione alla base della lunetta del portale d'ingresso, è riferibile alla prima metà del XII secolo.
Nella lunetta sono raffigurate testine umane e di animali che rispondono ad uno stile che ricalca di molto le raffigurazioni infantili.
Certamente l'opera di uno scalpellino non troppo dotato tecnicamente che pur restava iconograficamente nella linea del secolo, raffigurando un confronto tra un agnello crucifero ed un leone alato: l'eterna lotta tra il bene e il male.
Il maestro realizzò contemporaneamente le sculture dei capitelli dell'interno, scolpendo foglie ed animali dello stesso tipo della lunetta.
All'interno della chiesa, terminante in tre piccole absidi, dove un effetto suggestivo è generato dalla semioscurità e dalla pietra viva delle pareti, sono di notevole importanza una lastra, attualmente sistemata presso l'altare maggiore, che raffigura dodici personaggi intorno ad un tavolo con vivande (per alcuni studiosi è l'ultima a cena per altri una riunione conviviale tra i monaci del posto e l'abate di Montecassino) e l'ambone che è posto ai margini della navata centrale.
Quest'ultimo risente senz'altro di una risistemazione che negli anni trenta coinvolse, con la perfetta buona fede degli esecutori, l'intero edificio. Lo si comprende anche da una serie di piccoli frammenti ed alcune lastre poste ai lati.
Sono originali i capitellini, con raffigurazioni zoomorfe, le basi, e la parte alta del prospetto che è sostenuta da archetti.
Qui vi sono sette nicchie. Quella centrale è occupata da un'aquila reggileggio della quale restano solo gli artigli. Invece, accanto, vi sono figure di monaci e preti. A sinistra una scena liturgica con un vescovo affiancato da un chierico che regge un messale e da un altro che maneggia un turibolo, dall'altro lato, l'abate, all'estrema destra, è preceduto da un frate cercatore e da un orante. L'ambone è datato 1223.
A pochi chilometri da Santa Maria di Canneto, all'apice del centro storico di Trivento, un piccolo comune che osserva dall'alto la vallata del Trigno, la cripta di San Casto, sottostante alla chiesa Cattedrale, rappresenta un tipico esempio di riutilizzo di un luogo sacro romano in epoca cristiana.
Molto probabilmente la trasformazione del limitato ambiente avvenne nell'Alto Medioevo, anche se i capitelli, caratterizzati da pitture zooomorfe e creazioni geometriche, sistemati alla buona e secondo alcuni studiosi appartenenti all'Alto Medioevo, fanno riferimento al XII secolo.
La cripta fu, comunque, ancora frequentata successivamente, considerata la lunetta gotica che ancora vi è conservata.
Sicuramente il riutilizzo di elementi architettonici di epoca romana ed altomedievale ed altre risistemazioni avvenute dopo lo stesso Medioevo hanno potuto far pensare ad una datazione anteriore al XII secolo dei capitelli, che, invece, presentano caratteristiche comuni a tutte le altre opere locali dello stesso periodo.
E' difficile, proseguendo verso il Molise centrale ed oltre, verso la costa, individuare , a livello formale , la presenza di una scuola scultorea che dia carattere di uniformità all'arte romanica locale. A Campobasso le Chiese di San Giorgio e San Bartolomeo, entrambe all'apice del centro storico, nei pressi del castello Monforte, realizzate nell'arco del XIII secolo, mostrano evidenti differenze artistiche.
La prima, presenta, oltre a lastre erratiche murate lungo i muri perimetrali, tra le quali sono importanti quelle (raffiguranti un pellicano, un'umanizzazione del sole ed una testa di toro, la lunetta del portale centrale con agnello crucifero.
La seconda invece, sempre nella lunetta del portale, mostra l'ascensione del Cristo in un guscio di mandorla, trainato da angeli ed attorniato da simboli di profeti e degli evngelisti, che rimanda ad analoghe raffigurazioni riscontrabili nell'attuale Puglia.
L'agnello crucifero si ritrova in una lunetta riutilizzata presso il fonte battesimale nella chiesa di santa Maria Assunta a Ferrazzano , dove è notevole anche il portale con la raffigurazione di un pavone, simbolo di eternità.
Gli edifici sacri più importanti della zona, sono comunque quelli di Petrella Tifernina e Matrice. Il primo è dedicato a San Giorgio Martire e, stando ad un'iscrizione sulla lunetta del portale principale, fu eretto, nella forma ancora oggi visibile, nel 1211.
L'intero apparato scultoreo della chiesa, di sicura mano germanica, riconduce ad echi di un mondo popolato da animali selvaggi, trasformazioni demoniache (lunetta del portale laterale sinistro), percorso dalle lusinghe e dalle tentazioni al peccato delle sirene (capitelli interni).
La raffigurazione senz'altro più importante è quella della lunetta centrale dove un mostro marino, lontanamente assimilabile al Simurgh islamico, prima ingoia e poi rigetta il profeta Giona, riproducendo la simile sequenza della chiesa di Santa Croce ad Aght'Amar in Armenia (X secolo).
Simile episodio rientra tra le sculture del protiro della chiesa di Santa Maria della Strada di Matrice (XII secolo), dove però il drago mantiene ancora forme evidentemente orientali.
La chiesetta di Matrice, divisa in tre navate con i capitelli dell'interno decorati con forme vegetali, mostra un ricco apparato scultoreo che va dal patrimonio classico (protiro) a leggende medioevali. La lunetta cieca sinistra della facciata riproduce un episodio della Chanson de Fioravante, mentre quella della fiancata destra l'ascensione di Alessandro Magno al cielo.
Sulla stessa direttrice di Matrice possono essere poste le sculture dei capitelli della Cripta di Sant'Adamo a Guglionesi, già avviandosi verso la costa adriatica. In particolare alcune riproduzioni di testine umane rimandano alla cripta dello Spirito Santo a Monopoli (XII secolo).
Sono decisamente decorate con aggraziati motivi vegetali i capitelli delle cripte di San Nicola a Guglionesi e di Santa Maria a Mare a Campomarino, entrambe del secolo XII .
Non è, in definitiva, estremamente ricco di esempi, dal punto di vista quantitativo, il romanico molisano. Riesce però, sul piano della narrazione, ad essere suggestivo, fedelmente al periodo che rappresenta, quando cioè la verità era nascosta nei fumi dei sortilegi di maghi e streghe.
E le sculture delle chiese molisane tracciano l'itinerario di un viaggio che va a perdersi nel mistero di sirene e simurgh.
La proprietà fotografica e letteraria appartiene ai legittimi proprietari
Web Design: ARS idea studio


